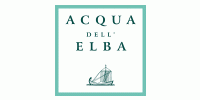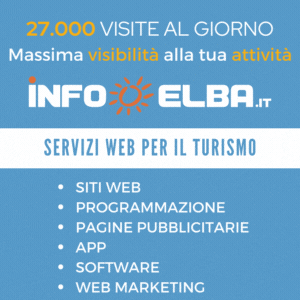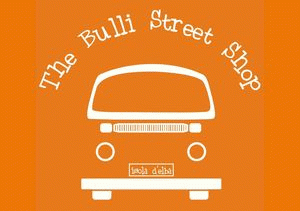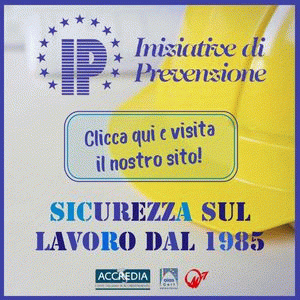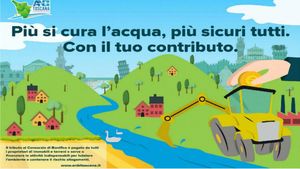Uno degli impianti minerari più importanti nel processo che intercorre tra l'estrazione e il caricamento sui bastimenti, è la laveria, dove il minerale, ridotto in piccole pezzature, veniva depurato dalle scorie terrose, per poi essere imbarcato verso i centri siderurgici. I miglioramenti tecnici di questi stabilimenti fu costante per oltre un secolo, in modo che il minerale arrivasse con meno impurità possibili al processo siderurgico, in quanto anche minime percentuali di sterile potevano ostacolare la resa degli altiforni.
La prima laveria elbana, per quanto molto arcaica, fu costruita a Rio Marina a metà Ottocento, nel cantiere Bottaccio. Il minerale veniva accumulato in pendenza e posto sotto l'azione dell'acqua, che scendeva per caduta attraverso un canale dal bottaccio che dava il nome al luogo. Per quanto non molto efficace, parte delle argille e la puletta, erano depurate. Questo lavaggio doveva durare molte ore, poiché solo dopo uno o due giorni il minerale lavato veniva portato ai depositi a dorso di muli e tramite coffe. Del trasporto si occupavano gli operai anziani e i ragazzi.
Il primo impianto industriale è datato pochi anni dopo, progettato dall'ingegner Theodor Haupt nel 1852, e realizzato nel luglio 1855, entrando in funzione l'anno successivo. Oltre alla laveria, il progetto prevedeva la realizzazione di uno Stabilimento di concentrazione, da costruire nella parte alta della valle di Riale. Questo impianto era composto di parecchi tamburlani mobili atti a pulire e separare in diverse classi il minerale, di più macchine a crivello, di un labirinto o forse di una cassa tedesca per la concentrazione del medesimo. Il 13 marzo 1854 però il governo bocciò il progetto dello Stabilimento, dando il via libera alla sola laveria.
Fu costruita, come scrive un certo Pietri, capitano di gita, all'argine del fosso del Riale, a ovest dell'imboccatura del fosso del Pietramone. I lavori sono descritti dallo stesso autore: “La parte superficiale era tutta gettata della miniera. Furono aperti i fondamenti e dalla parte del fosso la gettata seguitò per un pezzo. Dalla parte d'Ovest fu trovato, presto, vergine del Pietamone, vale a dire terra argillosa, di un colore giallognolo con qualche blocco di minerale oligisto a guisa di ghiaia arrotondata; altrettanto fu dalla parte di Nord e di Est. Finiti i fondamenti, furono da ogni parte battuti nel fondo paloni di pino, ma molto più lunghi furono piantati dalla parte del fosso di Riale, per maggiore stabilità del muramento. Appena terminato di battere i paloni nei fondamenti, fu dato principio al muramento e non si cessò fino a che non si vide finito lo stabile”.
Ad azionare la laveria era un “rotone” idraulico, mosso dalla stessa acqua utilizzata per il lavaggio. Ecco come la laveria si presentava nella descrizione di Gastone Garbaglia: “era composto da un cassone fisso nel quale venivano, a mezzo di tramoggia, gettate le terre che da questo cassone scendevano, spinte dall'acqua, in quattro cassoni mobili sottostanti (due per parte)”. Specifica Pietri: “Queste quattro casse mobili ricevevano una scossa per mezzo dell'albero del rotone che le faceva muovere; ma ci voleva più assai che le scosse del rotone per lavare le terre di minerale di ferro: questo sistema sarà forse affidabile a terre di piombo e argento, non a quello delle gettate di ferro”.
Prosegue Garbaglia: “Questi cassoni a loro volta versavano il materiale entro due tamburi di rete di ferro”, o per usare le parole di Pietri “due tamburlani fatti di filo di ferro che giravano per mezzo di una cinghia attaccata all'albero del rotone”. I tamburi, spiega Garbaglia, “non lasciavano passare il materiale in pezzatura convogliandolo alla loro estremità dove cadeva entro i vagoni, mentre il materiale fine che passava dalle maglie era raccolto in canali posti al disotto dei tamburi e veniva quindi convogliato su delle tavole a scossa dove si cercava di separare la puletta, o minerale fine, dalla terra”. Queste tavole a percussione ricevevano la scossa, dice Pietri “da un dente attaccato all'albero del rotone mentre girava”.
L'acqua era presa dal fosso della valle dei Mulini, poco sotto Rio, convogliata in una gora di 490 metri. La stessa acqua però alimentava diversi mulini e serviva per irrigare molti orti. La direzione delle miniere dovette quindi garantire che ritornasse al fosso, ovviamente depurata. Per far questo vennero costruiti alcuni bottacci, in cui finiva l'acqua di lavaggio, di modo che i residui solidi si depositassero sul fondo. Ma l'acqua di scarico era comunque sporca e non adatta per l'irrigazione.
Per lavare i bottacci dal fango, e recuperare eventualmente la puletta, furono acquistate le sorgenti del Favale, poiché l'acqua del solo gorile era insufficiente. Dalle sorgenti fu costruita una condotta coperta, costituita di due rami, inframezzati da una cisterna, in località la Rotonda. Il primo tratto era lungo 196 metri, mentre il secondo, dalla cisterna alla laveria, era un gorile che scorreva nella galleria dell'Ornello.
Con l'acqua delle stesse sorgenti era stato progettato un sistema di laveria a pale, consistente in cinque casse idrauliche, “le quali non erano altro che delle piccole torri messe a cavallo del gorile che scendeva lungo il fianco della collina con forte pendenza”, scrive Garbaglia. L'acqua, agendo sulle pale, muoveva le ruote dei vagli, caricati a mano delle terre da lavare. Ma il progetto fu abbandonato, in quanto l'acqua non era sufficiente per alimentare cinque vagli e la sottostante laveria.
L'impianto infatti rivelò subito la sua inefficacia. L'insufficiente quantità d'acqua non riusciva a lavare bene le terre troppo argillose delle cave. Inoltre Pietri annotava i difetti tecnici delle attrezzature: “Queste tavole [a scossa] lavoravano la puletta, gettandogli sopra la terra fangosa che veniva dal lavaggio, ma era così poca la puletta che si otteneva da questa lavatura che convenne poco dopo smettere. E ciò fu nel 1856 e '57. […] I tamburlani e le tavole a percussione, conoscendo che non erano adatti a questo lavoro, ebbero poca vita”. Per ovviare ai problemi furono tolte, oltre le tavole a scossa, le quattro casse mobili, sostituite con altrettante fisse, “dentro le quali si metteva la terra e ci si faceva cascare l'acqua”. L'operazione di sfangatura fu quindi affidata a uomini con appositi arnesi. Ma oltre che essere un lavoro faticoso, il risultato rimase scadente; “si poteva ottenere alla meglio un poco di ferrino”, scrive laconicamente Pietri. Così nel giugno 1859 la laveria fu profondamente ristrutturata, come vedremo nella seconda parte.
A conclusione di questo capitolo può essere interessante specificare il significato di una parola incontrata sopra, e che oggi probabilmente ai più non dice molto: puletta. Quando l'acqua di lavaggio del minerale veniva scaricata in mare si portava minuscole scaglie ferrose, la puletta appunto. Un processo di separazione e recupero di essa avveniva in maniera naturale: soprattutto per opera del mare, con l'azione di risacca, ma in misura minore anche dei fossi. Essi agivano come una sorta di laveria naturale: nel loro costante flusso e riflusso, le terre ferrifere che finivano sul fondo marino o nell'alveo dei fossi erano setacciate, e la puletta andava ad accumularsi sulle spiagge minerarie e ai bordi dei corsi d'acqua, creando quei banchi di sabbia scurissima e luccicante dei cristalli di ematite. I cavatori potevano così recuperare quintali di prezioso materiale ferroso senza la fatica dell'escavazione e con la relativa facilità di raccoglierlo in masse già approntate dalla natura. Un processo che non si è arrestato neanche con la chiusura delle miniere: ancora oggi, soprattutto sulle spiagge in prossimità delle cave dismesse, è possibile vedere ancora ammassi di puletta, che formano affascinanti arenili sabbiosi neri e scintillanti al sole, molto apprezzati dai turisti.
Andrea Galassi